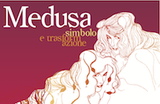|
Cosa intendiamo per spazio interiore? Innanzitutto ciò che è possibile per noi percepire, ma, allo stesso tempo, ciò da cui veniamo influenzati, che, anche se non riusciamo ad avvertire, esiste e si muove al nostro interno. Ciò che definisce chi siamo è possibile focalizzarlo attraverso lo Spazio Esperito, quello che sperimento, e lo Spazio in Essere, quello che io sono nel complesso. Questi aspetti sono governati dalla coscienza, ovvero, l’insieme dei nostri stati del sentire che hanno la possibilità di divenire esperienza. La coscienza di ciò che si è, o si sperimenta, è sempre reale per l’individuo perché determinata dai processi neuronali all’interno del cervello, frutto del funzionamento di processi neurobiologici. Quando le percezioni sono attivate in modo voluto determinano il nostro Spazio Esperito, quello che siamo nel complesso. Esistono altri processi inconsci che causano dei comportamenti di cui non riconosciamo in modo chiaro il loro essere presenti, tali processi fanno parte di uno Spazio in Essere, ovvero, quello che sperimentiamo di un interno che dispiega le proprie modalità attraverso una complessità di processi non completamente riconoscibili, ma che concorrono a determinare la nostra soggettività. Parlare di uno spazio interno vuol dire anche sottolineare il bisogno umano di linee di demarcazione per poter riconoscere i confini che qualificano la realtà di ognuno, costituita da componenti soggettive, tipiche in ogni persona. Grazie a tutte queste caratteristiche legate alla coscienza possiamo sperimentare il mondo circostante in maniera personale e coglierne aspetti in grado di caratterizzare lo scambio in relazione alla soggettività e all’esperienza di ognuno, riuscendo così ad integrarla in noi. Entrambi gli aspetti dello Spazio Interiore si formano attraverso immagini sensoriali di diverso tipo - visive, uditive, tattili, gustative e olfattive - che si creano attraverso eventi ed oggetti del mondo che ci circonda. Le immagini hanno un duplice ruolo: da un lato possono essere osservate come elementi della coscienza, dall’altro contribuiscono alla costruzione dei sentimenti, i quali sono un elemento costitutivo della soggettività. I fattori fondamentali della soggettività, che qualificano lo Spazio Interiore, si fondano in un processo che poggia su due componenti essenziali: l’elaborazione di una prospettiva propria per le nostre immagini mentali e l’accompagnamento di queste immagini da parte dei sentimenti. Questi due elementi definiscono ciò che per noi è soggettivo: quella condizione che si crea quando i nostri sentimenti sono collocati in rapporto a qualcosa, dunque all’interno di una prospettiva che li rende adeguati, così da divenire importanti e qualificanti per noi. “[...] quel senso del mio che permette di accedere all’universo dell’individualità. Le esperienze mentali hanno dato alla mente un nuovo impulso, avvantaggiando innumerevoli specie. E nell’uomo, le esperienze mentali hanno direttamente influenzato la costruzione deliberata delle culture: le esperienze mentali di dolore, di sofferenza e di piacere sono diventate le fondamenta dei desideri umani, pietre miliari di invenzioni umane, in netto contrasto con l’insieme di comportamenti assemblati fino a quel punto dalla selezione naturale e dalla trasmissione genetica.” (A. Damasio, “Lo Strano Ordine delle Cose”, p.184) Le osservazioni di Damasio ci spingono a chiederci cosa qualifichi la coscienza. Un ruolo fondamentale è caratterizzato dai sentimenti e da come possiamo trattarli partendo da due concetti basilari:
Generalmente si pensa che esercitare i sentimenti debba passare solo per attività impegnative mentre, ad esempio, il gioco, o la cooperazione tra persone, sono in grado di riversare sull’individuo sensazioni molto piacevoli, ed è per questo che è importante poterle ricreare soprattutto al giorno d’oggi dove si è protesi ad impegnarsi in attività produttive nei termini di una resa immediata. L’altro elemento molto importante risiede nel considerare che i sentimenti si sono sviluppati nel corso dell’evoluzione e che si sono conservati perché i loro contributi, in seno alla stabilità vitale dell’organismo, hanno giocato un ruolo di estrema importanza dando solidità ai processi umani. Ma come possiamo trattare questi sentimenti che sorreggono le nostre esistenze? Come orientarci al loro interno? Innanzitutto prestando loro attenzione e, poi, attraverso la conoscenza di una grammatica dell’interiorità. Gli elementi che costituiscono lo Spazio Interiore sono: 1. l’attenzione - L’attenzione si può rappresentare come l’aprire un varco dentro il chiasso interiore, vedere attraverso una porta, creare un dialogo con le cose e generare pienezza dentro di noi. “[...] Nello spazio dell’interiorità l’attenzione ha una duplice, e in un certo senso contraddittoria, funzione: da una parte allontana il tumulto dei pensieri, o lo stesso procedere ordinato dei pensieri, per imporre una relazione con l’esterno, con un accadimento, con un suono, con una parola, con un oggetto o linea o colore, dall’altra richiama tutti i sensi [...] come l’occhio interiore, o l’odorato interiore. L’attenzione interiore esplora, scruta, fiuta, osserva dentro, scende nel groviglio del sentire per distinguere e osservare da vicino e intendere. L’attenzione è sorella della concentrazione e della meditazione.” (A. Prete, “Il Cielo Nascosto”, p.170) 2. L’attesa - L’attesa è un passaggio interno collegato al primo elemento: l’attenzione. Quando si porta attenzione a se stessi, infatti, si scopre che il tempo rallenta, che non emerge subito ciò che serve, e spesso si entra in confusione. Saper sperimentare l’attesa richiede metodo, consapevoli che l’obiettivo è quello di poter riuscire a vivere il vuoto apparente che sorge mentre cerchiamo di guardarci, così da poter riconoscere la sua natura e di cosa sia fatto. È come quando stiamo al buio e lo sguardo non vede nulla, poi inizia a cogliere degli elementi e si stabiliscono dei punti di riferimento visivi, olfattivi o uditivi: i sensi si riposizionano per sperimentare il nuovo. “L’attesa piega il tempo fuori del suo ordine, fino a sospenderlo, o a renderlo trasparente, impalpabile, comunque lontano. Il prima e il dopo si separano, si allontanano l’uno dall’altro, si fanno estranei e non comunicanti, e in mezzo si posa l’attesa, in quel vuoto di tempo e azione, in quella suprema, bianca esitazione, in quel deserto dove nulla succede. [...] La lingua dell’attesa ha un alfabeto di annunci. Attendere è decifrare, con pazienza quotidiana questi annunci. [...] Attendere è tendere verso la presenza delle cose e delle persone con un’energia consapevole di un passaggio che verrà, di un distacco che porterà lontano.” (A. Prete, “Il Cielo Nascosto, pp.171-172) 3. Le parole nel silenzio - Le parole che si formano nel silenzio dell’ascolto sono parole piene, che riducono la propria tonalità ma che hanno il loro alfabeto perché evocano, raccontano, interrogano e si prestano ai sentimenti di gioia, come di tristezza. La parola nel silenzio crea un’atmosfera, è una parola svincolata dal dover andare verso qualcosa, liberata dall’obbligo, dunque in grado di sperimentare la libertà della lingua. La parola del silenzio è una parola meditativa, fissa dentro i vissuti, e li consegna all’individuo, restituendo il significato di un incontro con se stessi, intimo e pregnante, frutto di un indagine interiore. Un dialogo interno che orienta e sostiene, ma che a volte precipita nel silenzio impenetrabile che, per essere attraversato, esige spesso un segnale da fuori. La preghiera ne è un esempio: si utilizzano significati spirituali per dare voce a ciò che è muto. Diversamente, il lavoro terapeutico, interagisce cercando di coordinare i vari colori interni e dando loro un ordine espressivo. Anche nella poesia troviamo parole nel silenzio, un ascolto che diviene scrittura: “Non aver paura, sono io. Non senti che su te m’infrango con tutti i sensi? Ha messo ali il mio cuore e ora vola candido attorno al tuo viso. Non vedi la mia anima innanzi a te adorna di silenzio? E la mia preghiera di maggio non matura al tuo sguardo come su un albero? Se sogni, sono il tuo sogno ma se sei desto sono il tuo volere; padrone d’ogni splendore m’inarco, silenzio stellato, sulla bizzarra città del tempo.” (R. Maria Rilke, “Non aver paura sono io”, in “Libro d’Ore”, Servitium Editrice) Nella figura di Perseo troviamo traccia della coscienza così concepita, come uno spazio da calibrare. Un eroe che lotta per far emergere il significato di se stesso, di ciò che lui è in termini di cognizione e consapevolezza. “[...] possiamo dire che Perseo ha sposato il lato spirituale, è colui che è dotato di ali ed è alleato con gli dei dello spirito nel combattimento contro l’inconscio. La Gorgone uroborica, che dimora a occidente, nella regione della morte, circondata dalle sorelle, le Graie, che appartengono all’abisso primordiale, è l’elemento da vincere. Perseo sconfigge l’inconscio con un azione tipica: l’acquisizione di coscienza. Non potendo sostenere lo sguardo pietrificante dell’Uroboros, egli ne riflette l’immagine, cioè la porta alla coscienza e così la uccide. Il tesoro conquistato è Andromeda, la prigioniera liberata, e inoltre Pegaso, la libido spirituale della Gorgone liberata e così trasformata. Di conseguenza Pegaso è a un tempo simbolo del creativo e simbolo trascendente. Esso unisce la spiritualità dell’uccello con il carattere equino della Gorgone.” (E. Neumann, “Storia delle Origini della Coscienza”, Ed. Astrolabio, p.196) Lo Spazio Interiore è il regno della coscienza che spinge in direzioni diverse: verso l’adattamento all’esterno (le cose del mondo), verso l’adattamento all’interno (la psiche oggettiva e soggettiva), verso l’auto regolamentazione (la trasformazione dovuta alla tendenza evolutiva della psiche). Il meccanismo evolutivo di cui siamo intrisi procede sempre e, come dice Damasio, “i sentimenti hanno liberato dai loro ormeggi migliaia di navi intellettuali e hanno aiutato a pilotarle nel mare della vita” (“Lo Strano Ordine delle Cose”, Ed. Adelphi, p.266). Oggi ci troviamo a dover fare i conti con la difficoltà di calibrare i sentimenti rispetto al fluire delle cose in una società che è divenuta sempre più frammentata, dove si fa fatica a mettere assieme più aspetti per dare al tutto un senso: c’è molto poco tempo da dedicare all’esistere. Tuttavia, quando si vive un disagio, pensare in termini esistenziali ci riporta allo stare con se. Tale passaggio, che richiede cura ed attenzione, è necessario poterlo affrontare attraverso una grammatica che ci orienti.
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
|
|
NOTE LEGALI e CONDIZIONI DI UTILIZZO
I termini e le condizioni di utilizzo del sito web si applicano nel momento di accesso e/o utilizzo di questo sito web. Per saperne di più leggi la pagina note legali e condizioni di utilizzo del sito. |
PRIVACY e RETARGETING
Questo sito web usa Google Analytics per l'analisi delle visite e del traffico, inoltre utilizza il pixel di tracciamento di Facebook per fare retargeting. Per saperne di più leggi la PRIVACY POLICY. |

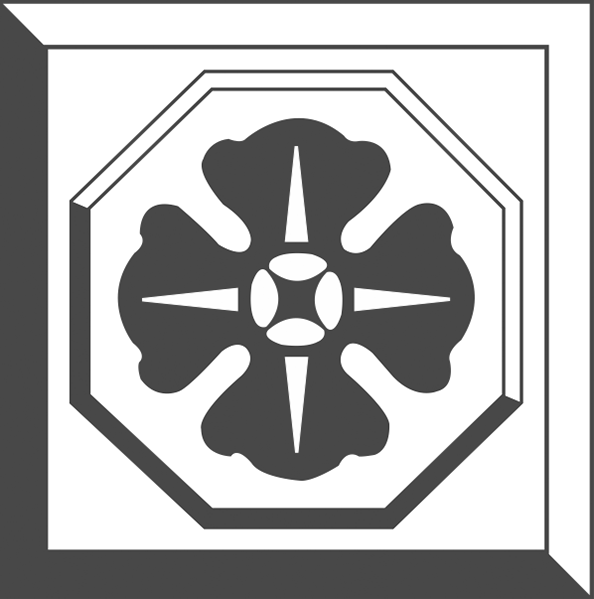
 Feed RSS
Feed RSS